"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi

"Il bruco" (2017). Nikon Coolpix P900. Foto macro. Stato larvale della falena diurna "Macroglossum stellatarum" volgarmente detta "sfinge colibrì".
mercoledì 26 giugno 2024
martedì 25 giugno 2024
lunedì 24 giugno 2024
domenica 23 giugno 2024
sabato 22 giugno 2024
mercoledì 19 giugno 2024
martedì 18 giugno 2024
sabato 15 giugno 2024
giovedì 13 giugno 2024
martedì 11 giugno 2024
lunedì 10 giugno 2024
sabato 8 giugno 2024
venerdì 7 giugno 2024
giovedì 6 giugno 2024
mercoledì 5 giugno 2024
martedì 4 giugno 2024
lunedì 3 giugno 2024
domenica 2 giugno 2024
Iscriviti a:
Commenti (Atom)

.jpg)

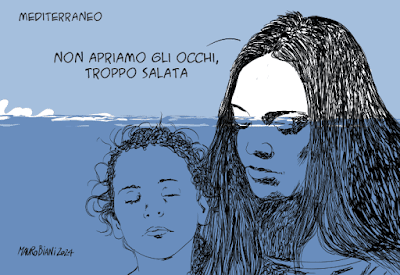


.jpg)

.jpg)







.jpg)

.jpg)