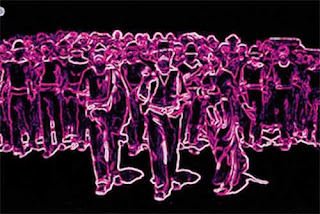Da “Il Paese dei penultimi” di Ilvo Diamanti, pubblicato sul
quotidiano la Repubblica del 30 di aprile dell’anno 2012: (…). La fine del berlusconismo
ha, (…), decretato anche la fine della grande illusione. Che tutti gli italiani
potessero diventare come Lui. Il Cavaliere. Con molta fortuna e altrettanta
spregiudicatezza, un po' di senso cinico al posto di quello civico. Gli
italiani: un popolo di partite Iva e di imprenditori. Di ceti medi pronti a
salire ancora nella scala sociale. Il "sogno italiano", interpretato
per quasi un ventennio da Berlusconi, sembra finito in modo brusco. Perfino
violento. Gli italiani che si sentono "ceto medio" sono, infatti,
calati dal 60%, nel 2006, al 44% di oggi. Mentre il "mito
dell'imprenditore" appare in rapido e profondo declino. Solo 2 italiani su
dieci, per sé e i propri figli, ambiscono a un lavoro in proprio. Nel 2004
erano il 31%. Ancor meno, il 16%, sperano in una carriera da liberi
professionisti. Un anno fa erano quasi il 23%. Parallelamente, ha recuperato un
grande appeal l'impiego pubblico. In testa alle aspirazioni del 34% degli italiani:
5 punti in più dell'anno scorso. È il mito del posto fisso che si fa largo e
resiste. Nonostante che, nell'ultimo anno, solo il 30% delle persone dichiarino
di aver lavorato "regolarmente tutti i mesi". O forse proprio per
questo. Cioè: perché in un mondo instabile, la flessibilità, se è priva di
prospettive e di tutela, sconfina nella precarietà. Alimenta incertezza. Per
questo il 55% degli italiani si accontenterebbe di un lavoro di qualsiasi tipo,
ma stabile. Non importa che piaccia, a condizione che sia sicuro. Insieme al
berlusconismo pare svanito anche il suo complemento psicologico: l'ottimismo.
Fino a un anno fa, era l'ideologia del tempo. Un obbligo e un imperativo
"nazionale". Dirsi pessimisti significava dichiararsi anti-italiani.
E, quindi, (almeno un po') comunisti. (…). Questo Paese, più che perduto,
appare, dunque, popolato di "perdenti". Gli "ultimi",
coloro che si sentono di posizione sociale bassa. I più colpiti dalla crisi.
Insieme ai "penultimi", quelli che si dichiarano di classe medio-bassa.
Il che significa, soprattutto, i lavoratori dipendenti privati, i pensionati,
le casalinghe. La popolazione del Mezzogiorno. (…). Un Paese smarrito. Dove la
maggioranza delle persone ritiene troppo rischioso investire nel futuro. Dove
la fiducia negli altri è, ormai, una merce rara. Espressa da due persone su
dieci. Dove, di conseguenza, ci si sente stranieri, perché il
"prossimo" si è eclissato e gli "altri" ci appaiono
minacciosi. Stranieri fra stranieri. Da ciò la differenza sostanziale dalle altre
crisi che abbiamo affrontato, nel dopoguerra. Ieri - e ancor più ieri l'altro -
credevamo in noi stessi e investivamo nelle virtù, ma anche nei vizi, del
nostro carattere nazionale. Il lavoro, la famiglia, il risparmio. L'arte di
arrangiarsi. Eravamo sicuri che ce l'avremmo fatta, comunque.
"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi

"Il bruco" (2017). Nikon Coolpix P900. Foto macro. Stato larvale della falena diurna "Macroglossum stellatarum" volgarmente detta "sfinge colibrì".
domenica 30 aprile 2017
sabato 29 aprile 2017
Scriptamanent. 92 “La colpa del male”.
Da “La colpa del male” di Adriano Sofri, pubblicato sul quotidiano la
Repubblica del 29 di aprile dell'anno 2013: Nell’incattivimento di una società, c’è
almeno un concorso di colpa. Nella gara accanita all’irresponsabilità, siamo a
questo punto: che ci si è rassegnati a non confidare più nella giustizia, e si
ripiega sulla vendetta. “Un gesto eclatante”: non per trovare un lavoro
migliore, o semplicemente un lavoro, non per far riconoscere le proprie
ragioni, non per divincolarsi da debiti e umiliazioni. Per finirla col botto.
Per vendicarsi. E chi agisce per vendicarsi, cerca negli altri almeno un
posticino in cui farli sentire oscuramente vendicati. Arriva un giorno in cui
la frase così affabilmente consueta a tante donne e uomini perbene, che a
Montecitorio bisognerebbe metterci una bomba, ti fa mordere la lingua. “I
politici” sono diventati la spiegazione della rovina e del malumore di un
popolo e dei suoi membri solitari e perduti. La rovina succede, e può
travolgere ogni riparo. Disgrazia si aggiunge a disgrazia, finché non si abbia
più forze e speranze per provare a uscirne. (…). La rovina si compie prima di
tutto nel linguaggio. La rete non lo suscita, lo rivela, e lo favoreggia. Nella
guerra spietata che i ricchi conducono contro i poveri, gli impoveriti scelgono
il bersaglio dei “politici”, cioè degli arricchiti. Ridistribuire la ricchezza
sarebbe un atto di giustizia. Far fuori “i politici” è una vendetta. Non riduce
lo stridor di denti, ma lo premia. Poi, come succede, si spara a due
carabinieri da 1.400 euro al mese. (…). Compagni di scuola, avventori del
grande magazzino, passeggeri del proprio treno: un gesto “eclatante”,
attraverso cui lasciare un segno del proprio misconosciuto passaggio. (…).
venerdì 28 aprile 2017
Paginatre. 83 “80 anni da Antonio Gramsci”.
27 di aprile dell’anno 1937, ore 4,40: muore a Roma,
nella clinica “Quisisana”, Antonio Gramsci. Da “La scoperta della libertà” di Maurizio Viroli, pubblicato su “il
Fatto Quotidiano” del 18 di aprile 2017: (…). Nel 1975 esce (…) per Einaudi, sotto
l’egida dell’Istituto Gramsci, la prima edizione critica dei Quaderni del
carcere, a cura di Valentino Gerratana. Su quei quattro volumi furono promosse
molte iniziative e si aprì un importante dibattito culturale e politico sul
concetto di egemonia, sul rapporto fra democrazia e socialismo, sul ruolo e la
natura del partito, sulla Rivoluzione d’Ottobre, sugli intellettuali, sulla
storia d’Italia, sulla questione meridionale. A Gramsci va riconosciuto il
merito storico di aver avviato nel mondo comunista la consapevolezza che non
era possibile in Italia seguire la via della Rivoluzione d’Ottobre. Lo ha fatto
con l’unico argomento che poteva essere efficacie, vale a dire la
considerazione realistica delle condizioni storiche. Sarebbe sbagliato
sostenere che Gramsci aveva capito che la trasformazione socialista della
società deve avvenire soltanto nel pieno rispetto delle libertà civili e delle
regole democratiche. Ma una volta dichiarato che la via sovietica non poteva
essere percorsa, che il proletariato “può e deve essere dirigente [vale a dire
ottenere il consenso degli altri gruppi sociali] già prima di conquistare il
potere governativo”, e che deve continuare ad essere dirigente anche dopo la
conquista del potere, restava aperta, di fatto, soltanto la via democratica. L’intuizione
più felice di Gramsci è a mio giudizio l’idea della “riforma intellettuale e
morale”. In un passo delle ‘Noterelle sul Machiavelli’, la descrive come “elevamento
civile degli strati depressi della società”, simile, per la sua capacità di coinvolgere
ampi strati delle classi subalterne, alla Riforma protestante e
all’illuminismo, ma capace di conservare e rielaborare “i caratteri di
classicità della cultura greca e del Rinascimento italiano”. E giustamente
sottolinea che la riforma intellettuale e morale “non può non essere legata a
un programma di riforma economica , anzi, il programma di riforma economica è
appunto il modo concreto con cui si presenta ogni riforma intellettuale e
morale”. “Banditore” della riforma intellettuale morale doveva essere per
Gramsci, il “moderno Principe”, il partito comunista, che diventa, nella sua
visione, non più un’avanguardia volta esclusivamente al lavoro di agitazione e
organizzazione in vista della conquista del potere politico, ma un partito
educatore e formatore di coscienze, una vera e propria scuola dove gli elementi
migliori delle classi subalterne imparano a dirigere il complesso della vita
sociale alla luce di ideali di emancipazione. Il limite dell’idea gramsciana
della riforma intellettuale e morale non non risiede nella sua concezione del
partito politico come educatore e formatore di coscienze, ma nella sua
convinzione che il partito della classe operaia debba essere il punto di
riferimento del giudizio morale e politico: “il moderno Principe sviluppandosi
sconvolge tutto il sistema dei rapporti intellettuali e morali in quanto il suo
svilupparsi significa appunto che ogni atto viene concepito come utile o
dannoso, come virtuoso e scellerato, solo in quanto ha come punto di
riferimento il moderno principe stesso e serve a incremenatre il suo potere o a
contrastarlo”. Il Principe, conclude Gramsci, “prende il posto, nelle
coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico” (Quaderni del carcere,
vol. III, p.1561).
giovedì 27 aprile 2017
Sfogliature. 77 “La politica al tempo dell’estrema destra economica”.
Tendevo, molto interessato, l’orecchio. E porgevo ora l’uno ora l’altro
al fine di cercare la condizione migliore per la captazione di quel loro
parlare. E sì che l’età mi ha fatto perdere un buon fascio delle frequenze
uditive ma lo sforzo, anzi il gioco innocente nell’occasione, ne valeva la
candela, come suol dirsi. E così mi sono ritrovato ad ascoltare con
indifferenza, senza darlo ad intendere. Veniva riferito, tra gli astanti, di un
dibattito tra due figure storiche della politica e del sindacalismo del bel
paese, della sinistra insomma. Non ho captato in quale trasmissione televisiva
i due, l’uno e l’altro li chiamerò d’ora innanzi, si azzannassero senza pietà e
senza risparmio alcuno. Accusava l’uno l’altro di non difendere più gli interessi
dei lavoratori del bel paese. È che, l’uno, in verità, da ben troppo tempo aveva
preferito frequentare i salotti buoni della capitale e le scene televisive
sfoggiando sempre una “mise” non
proprio da proletario arrabbiato. E poi, che dire di quel suo, all’apparenza
innocente, far ciondolare con grande “nonchalance”
gli astucci portaocchiali più eleganti, più pregiati ed in colore con la “mise” del momento? Che goduria alla
vista! E l’uno a sostenere come l’altro fosse rimasto un vetero-sindacalista,
un dinosauro della politica, pronto a difendere l’indifendibile ora che la
prepotenza, a detta del nostro da assecondare,
dei mercati globalizzati s’avanza
inarrestabile. Ha sostenuto Zygmunt Bauman in una Sua pubblica dichiarazione del
10 di agosto – che è stato il giorno del più massiccio crollo delle borse e
delle aziende del bel paese: Milano – 6,6%; FIAT – 8%; Banca Intesa – 13,72%;
Unicredit – 9,37%; MPS -7,8% - nel bel mezzo della canicola ferragostana: “Le disuguaglianze sociali, di qualunque
genere siano, derivano dalla divisione tra coloro che hanno e coloro che non
hanno”. L’uno avrà dimenticato questa semplicissima regola sociologica,
frastornato com’è dalle frequentazioni dei salotti buoni della capitale e dalla
occupazione costante della scena televisiva. Avrà dimenticato, l’uno, come la
storia del mondo insegni che solo l’unione degli esseri umani più emarginati,
in virtù sempre dei bisogni primari da soddisfare, o dei diritti da conquistare
e/o delle ideologie d’uguaglianza da far trionfare, abbiano fatto camminare la
storia stessa. Sarebbe stato interessante chiedere a quell’uno cosa rimarrà,
nell’immediato futuro, da contrapporre validamente, come turrito bastione a
tutela e difesa di tutti “coloro che non
hanno”, nello scontro sociale e politico inevitabile, ora che le nebbie
sembrano volersi sollevare e le brutture dei mercati tornano a mostrarsi con
tutta la loro ingordigia, cosa rimarrà da contrapporre, dicevo, allo strapotere
di quegli stessi mercati nel momento in cui si propugna da alcuni pulpiti, sfacciatamente,
una frantumazione ed una arrendevolezza delle “classi” sociali meno abbienti sulle quali i mercati scaricano
malvagiamente i loro errori e che sono chiamate a sanare i pubblici bilanci dissestati
intaccando così le loro scarse risorse economiche e finanziarie e vedendosi
decurtare i già falcidiati stati sociali. Eppure quell’uno si è sempre
professato “uomo di sinistra”. Ma di
quale sinistra? Forse ben si attaglia al personaggio nostro quanto ha scritto,
alla pagina 83, il linguista Raffaele Simone nel Suo pregevolissimo lavoro “Il mostro mite” – Garzanti editore
(2008) pagg. 170 € 12,00 -:
mercoledì 26 aprile 2017
Lalinguabatte. 32 “La fatica delle democrazie”.
Affermava Gustavo Zagrebelsky nel
corso di un colloquio con Ezio Mauro: “Gli Inquisitori (figura sempiterna)
direbbero che la libertà è infelicità e che proprio loro, essendosi assunti il
compito di liberare l'umanità dalla libertà, sono i suoi veri benefattori…”. Il
colloquio, che di seguito trascrivo in parte, pubblicato sul quotidiano “la
Repubblica” del 5 di maggio dell’anno 2011, è parte del volume “La felicità della democrazia” edito da
Laterza (2011) – pagg. 256, € 15 -. L’affermazione incontrovertibile del
professor Zagrebelsky è l’intuizione profonda di uno straordinario
intellettuale, uno dei pochi “maestri” viventi, punto di riferimento
di ogni pensiero che si voglia definire “liberale” o meglio ancora “libero”,
quest’ultimo nell’accezione più completa, quella che il pensiero illuminista ha
saputo e potuto diramare in questo angolo di mondo che è la vecchia, cara
Europa; intuizione profonda e straordinaria che conferma una convinzione mia personale
seconda la quale siamo in un’epoca di potente e pericolosa rimonta di una “controriforma”
non più strisciante ma incredibilmente palese, “controriforma” che non
ha mia tralasciato d’influenzare il vivere politico e sociale del bel paese.
Svuotare la democrazia del suo “senso” interno imprescindibile e
connaturato ad essa di continua ricerca di nuovi e sempre più avanzati
traguardi ed equilibri è stato da sempre l’obiettivo non confessato delle
continue manovre “controriformistiche” rese sempre più chiare con l’indicazione
chiara, venuta dall’alto, del nuovo
nemico del genere umano che sarebbe il cosiddetto “relativismo” storico. Le
“cadute”
ed il conseguente risorgere da esse, nel continuo giuoco democratico degli
equilibri nuovi sempre ricercati, vengono subdolamente fatte intendere come “inutilità”,
come spreco di energie, energie sociali e personali, che sarebbe opportuno
invece convogliare verso altri traguardi di poco o nullo spessore, come il
conseguimento dell’appagamento esclusivamente materiale delle proprie ambizioni
personali o di gruppo. La proposta “controriformistica” odierna ha al
suo interno la possibilità concreta di evitare le ricorrenti “cadute”
che le democrazie tutte mettono in conto come connaturate ad esse, ricorrendo, nelle
relazioni politiche e sociali di un mondo sempre più complesso, a figure ed
entità egemoniche ed incontrollabili con gli strumenti consueti della
democrazia, che libererebbero i singoli dal “disagio” delle opinioni, dal “disagio”
delle scelte pur sempre difficili a farsi e da quant’altro abbia a che fare con
la conduzione responsabile, collettivamente, di un assetto democraticamente
compiuto delle società del secolo ventunesimo. Scriveva Gustavo Zagrebelsky nel
Suo volume “Contro l’etica della verità”
– Laterza editore (2008) pagg. 172 €15,00 – alla pagina 123:
martedì 25 aprile 2017
Paginatre. 82 “27 di agosto 1944: una Storia”.
Da “Settant'anni
fa ci voleva un bel coraggio” di Vittorio Zucconi, pubblicato sul
settimanale “D” del 7 di febbraio dell’anno 2015: Quando mi sembra che tutto vada
per il peggio, tiro fuori un amuleto ingiallito. Che racconta una storia vera. Quando
mi sembra, come sembra a tutti noi adesso, che il mondo stia andando
all'inferno in carriola, quando ogni giorno l'informazione e Internet ci
bombardano, ci sgozzano e ci mitragliano con annunci di Apocalisse prossima
ventura, riprendo in mano un rettangolino di carta color avorio, poco poco
ingiallito dal tempo, come un amuleto. È l'annuncio di una nascita e del
battesimo di un bambino. I genitori, Anna e Mino, lo comunicano ai pochi
parenti e amici interessati al trascurabile evento, traboccanti di orgoglio e
di felicità nei caratteri ornati, dorati e molto kitsch. Non avrebbe davvero
nulla di notevole, quel "santino" come si diceva in passato, se non
fosse per la data: 27 agosto 1944. E il luogo: Bastiglia in provincia di
Modena. Nell'agosto del 1944, per i pochissimi che non ricordassero o sapessero
nulla della guerra in Italia finita 70 anni or sono (un po' di ironia, qui) la
città nella quale Anna e Mino si erano sposati e avevano messo al mondo un
figlio era il Fronte, la prima linea. Stormi di bombardieri americani
scavalcavano indisturbati gli Appennini e martellavano i nodi ferroviari e
stradali fra Bologna e Modena, l'ultima via di rifornirimento o di fuga verso
il nord per i Tedeschi ancora aggrappati alle montagne. Quei due, mi
raccontarono, erano andati a sposarsi di corsa in chiesa negli intervalli fra i
bombardamenti, come si fa attraversando una strada da un portico all'altro, fra
gli scrosci di pioggia. A pochi chilometri, nelle montagne che sovrastano e
spalancano la Bassa emiliana, i tedeschi in ritirata compivano massacri da far
vergognare le gang di terroristi in Siria o Iraq. Marzabotto, un mattatoio, è a
un'ora di auto da dove quel santino fu stampato. Di futuro, di sicurezza, di
lavoro, era meglio non occuparsi, anzi, meglio non pensarci proprio. Anna,
maestra di pianoforte, non aveva lavoro essendo non molti gli interessati a
studiare solfeggio nei rifugi antiaerei scossi dalle bombe. Il marito, Mino,
insegnava come supplente di Greco e Latino in un liceo privato, senza alcun contratto
né garanzie, coprendo in bici ogni giorno 32 chilometri fra la campagna e la
città, lungo strade e sentieri pattugliati da caccia inglesi e americani,
infestati da repubblichini e militi esasperati dall'odio che li circondava e da
partigiani con il dito nervoso sul grilletto dei fucili. Qualche volta lui
stesso, fresco sposo e padre, trasportava messaggi e armi per i partigiani,
sicura promessa di una brutta fine se fermato. Il futuro era la speranza di non
essere ammazzati, mitragliati, rastrellati, torturati, spediti in Germania. In
questa Italia del 1944, non soltanto quei due incoscienti avevano messo al
mondo un figlio senza alcuna assistenza sanitaria, ospedali, esami prenatali,
ecografia, ostetriche. In più - e questo è l'oggetto del mio sbalordimento e
della mia allegria - avevano sfidato i pericoli e le bombe per cercare una
tipografia ancora in funzione tra le rovine, una che potesse stampare santini
per annunciare la nascita e il battesimo di un figlio qualsiasi. Avevano scelto
il cartoncino avorio, i caratteri leziosi, l'immaginetta religiosa sulla
copertina, pedalando avanti e indietro per trovare qualcuno disposto a fare il
lavoro, con il brontolio lontano dell'artiglieria sulle colline, sicuramente
con i soldi di un nonno felice di spenderli. La loro unione, la nascita del
primo figlio, erano state più importanti della paura, della miseria,
dell'angoscia di un futuro che poteva essere lungo come la canna dei mitra
Schmeisser che i soldati tedeschi impugnavano, accampati nella stessa casa dove
Anna aveva partorito, oltre la porta della camera. Quel bambino, lo avrete
capito, ero io, Anna e Mino i miei genitori che non avevano avuto paura del
tempo, delle circostanze, dei tedeschi, dei repubblichini, delle bombe
americane. Forti nella certezza che nella vita non ci sono altre certezze che
quelle che si portano dentro di sè, soprattutto nelle ore più terribili, quando
sembra che il mondo stia andando all'inferno in carriola.
lunedì 24 aprile 2017
Primapagina. 37 “25 aprile, senza PD: un vuoto a perdere”.
Da “25
aprile, senza PD è anche meglio” di Maurizio Viroli, pubblicato su “il
Fatto Quotidiano” del 22 di aprile 2017: (…). So bene che molte cerimonie ufficiali
per il 25 aprile ispirano sentimenti di ribrezzo, soprattutto quando vediamo
sul palco figuri che parlano di libertà e dignità civile e nella loro vita non
hanno fatto altro che offendere l’una e l’altra. Ma questa non è ragione
sufficiente per proporre di abolire le cerimonie. La via giusta è piuttosto
impegnarci per fare sì che le celebrazioni siano dignitose, i simboli siano
coerenti con i valori della libertà, gli oratori siano persone che hanno
testimoniato con le azioni la sincerità del loro antifascismo. La regola aurea
delle celebrazioni del 25 aprile deve essere l’unità, o meglio lo sforzo di
tutti i partiti, i movimenti e le associazioni che si richiamano
all’antifascismo per rinnovare l’impegno a difendere la Costituzione e le
istituzioni repubblicane nonostante i contrasti di interessi, le ambizioni
personali, le differenze culturali e religiose. Non bisogna mai dimenticare che
nella Resistenza hanno militato comunisti e monarchici, liberali e socialisti,
cattolici, protestanti, ebrei e atei: chi auspicava una repubblica dei Soviet e
chi voleva salvare la monarchia; chi propugnava profonde riforme sociali e chi
intendeva difendere privilegi e diseguaglianze antichi; chi sperava di veder
nascere uno stato laico e chi preferiva rinsaldare il ruolo della Chiesa
cattolica. Non bisogna neppure dimenticare che il fascismo salì al potere
(chiamato da re Vittorio Emanuele III) grazie, in buona misura, alle divisioni
degli antifascisti e che Repubblica democratica non sarebbe sopravvissuta
all’attacco convergente del terrorismo rosso e nero, se non ci fosse stata
l’unità antifascista attorno alla Costituzione Repubblicana. Ma, evidentemente,
queste considerazioni che erano l’ABC dei vecchi partiti di sinistra, e di
tutti i politici seri dei primi decenni di storia repubblicana, sfuggono ai
moderni, spregiudicati e innovatori dirigenti del PD, a tal segno da non
trattenerli dall’annunciare che non parteciperanno alla manifestazione romana
promossa dall’ANPI perché la giudicano “divisiva”. Prendiamo atto, con profonda
commozione, della sincera preoccupazione per le divisioni che i dirigenti del
PD esprimono in occasione della manifestazione romana, quegli stessi dirigenti
che non hanno avuto alcun ritegno ad approvare a colpi di maggioranza una
riforma costituzionale che, se fosse passata, avrebbe creato una profonda
lacerazione nel corpo politico e avrebbe alienato molti italiani dalla
Costituzione e dalla Repubblica. Sia detto senza polemica, ma credete proprio
di poterci sempre ingannare? Dovere principale di un partito che si chiama
democratico sarebbe di agire in modo del tutto opposto, vale a dire gettare il
proprio peso politico e la propria autorevolezza (ammesso che ne abbia) per
attenuare i contrasti e per permettere a tutti gli antifascisti di sfilare con
piena dignità e, se necessario, fare un bel servizio d’ordine attorno alla
Brigata Ebraica. La scelta di non partecipare alla manifestazione romana nasce
probabilmente dal calcolo politico di avvicinarsi ulteriormente a Forza Italia,
e alla varie componenti del centro-destra, in vista di un’alleanza di governo.
Sappiamo tutti che Forza Italia, a cominciare dal suo fondatore che in tempi
poi non così lontani manifestò la sua ammirazione per Mussolini, è un partito
che ha poche simpatie per l’antifascismo e dunque sarebbe ancora meglio
disposto ad allearsi con un PD che non sfila con gli antifascisti. Renzi e i
suoi potrebbero organizzare per il 25 aprile una manifestazione con Forza
Italia, Alfano e Verdini, marciare compatti sotto uno striscione nuovo di zecca
con la scritta ‘Partito della Nazione’ tenendo alti poster giganteschi con
l’effige di Minzolini, simbolo dello strenuo impegno del PD e di Forza Italia a
combattere la corruzione politica. Gli amici dell’ANPI rechino invece in bella
evidenza la nostra Costituzione antifascista che abbiamo salvato dal PD, e
forse arriveranno molti giovani che sarebbero rimasti a casa, se il corteo lo
aprissero Renzi e Orfini.
domenica 23 aprile 2017
Primapagina. 36 “Ma Donald non lo sa”.
Dal nuovo “impero del bene” la corrispondenza “Scusi presidente, dov'è il dottore?” di
Vittorio Zucconi, pubblicata sul settimanale “D” del 15 di aprile 2017: (…). Alaa
al Nufa, così si chiama, uno sciamano lo è per davvero ma moderno, con una
laurea in Medicina conseguita a Damasco e una specialità in endocrinologia
pediatrica che era andato a prendere nella Università del Sud Dakota. Si era
sposato, cinque anni or sono,con una ragazza del posto. Aveva avuto una bambina
e aveva preso un impegno solenne al momento di partire dalla Siria: aveva
promesso alla madre vedova e alla sorella più grande, che avevano dedicato la
vita a lui per permettergli di studiare, di andarle a prendere e portarle a
vivere in America,magari in una zona un po' meno gelida della Grande Prateria
dei Sioux. Invece oggi Alaa il Siriano ad appena 32 anni è in trappola. Le
speranze di procurare un visto alla madre e alla sorella sono pari alla
temperatura media di gennaio a Sioux Falls, meno di zero. L'ipotesi di andare
lui a Damasco per far conoscere la moglie e la nipotina alla sua famiglia è da
scartare, perché il pericolo di restare bloccato è troppo alto per un musulmano
di ritorno da un viaggio in Siria. Il rischio più grave non è neppure al
rientro, ma all'uscita, perché lui è l'unico endocrinologo per centinaia di
chilometri di prateria specializzato nel trattamento di un male che affligge
sproporzionatamente i bambini e soprattutto i bambini delle riserve indiane: il
diabete. Attorno al suo studio, madri di varia carnagione formano circoli di
preghiera, ciascuna a divinità con nomi diversi, portano coperte e amuleti,
firmano petizioni per trattenerlo. Se lui se ne andasse o non potesse tornare,
migliaia di pazienti resterebbero privi di assistenza, perché i medici
specialisti disposti a vivere e ad esercitare la professione in uno Stato dove
il reddito medio è di un quinto inferiore alla media americana, e la pratica
della medicina ancora una vocazione missionaria, sono pochi. Come quei bambini
diabetici del South Dakota, così milioni di altri americani, grandi o piccini,
dipendono ormai per la loro salute da medici, infermieri, personale tecnico
venuto da lontano. Un medico generalista su tre non è nato in Usa e senza quei
dottori asiatici, africani, indiani, cinesi, europei, la prima linea di difesa
della salute, quella che accoglie l'80 per cento dei pazienti prima di
smistarli a specialisti o di mandarli a casa rassicurati con una pacca sulla
spalla e una ricetta, sarebbe sguarnita. Il 90 per cento dei piccoli ospedali
di campagna, quelli che offrono assistenza primaria, dai parti ai piccoli
interventi chirurghici, sparpargliati nell'immensità del grande ventre
americano, non potrebbe funzionare senza immigrati. E chi ha un bambino con le
coliche o un anziano caduto dalle scale non chiede a quale religione appartenga
il medico del pronto soccorso. Alaa al Nufa lo sa, come sa che probabilmente
non rivedrà mai più la madre, che ha 82 anni e, ironia crudele, soffre di
diabete, visto che difficilmente lei sopravviverà ai quattro o otto anni
dell'amministrazione in carica a Washington. Un medico islamico siriano resterà
per curare i bambini Sioux. Perché questa è la realtà del mondo di oggi.
sabato 22 aprile 2017
Paginatre. 81 “Lettera aperta ai padri tromboni”.
Paolo di Paolo, giovane scrittore (1983), si è
fatto conoscere su larga scala per il Suo volume “Dove eravate tutti” – Feltrinelli editore (2013) - con il quale ha
chiamato alla resa dei conti i tanti, tantissimi “padri tromboni” che nell’era
dell’egoarca di Arcore hanno fatto finta di non vedere, di non sentire e di
conseguenza non han parlato e così tacendo si sono resi corresponsabili dello
scempio compiuto da quell’uomo della vita politica e pubblica e della salute morale del
bel paese. Da “Padri tromboni maestri
d’ipocrisia” di Paolo di Paolo, pubblicato sul settimanale l’Espresso del 16
di aprile 2017: Cari Papà Tromboni, tutto bene? Vi trovate in quella strana fase della
vita - fra i cinquanta e i sessanta, o poco più - che pare dia un po’ alla
testa. A distanza di sicurezza della terza età, se non cadete nella classica
regressione (Peter Pan-insegue-Lolita), il potere è la vostra droga. Piccolo o
grande che sia, vi tiene comunque su di giri: dal lunedì al venerdì siete nella
bolla dei workaholic, non fate che bearvi della vostra agenda stracarica.
Sabato e domenica siete come palloni sgonfi. Per il resto, nient’altro che
cravatte, smartphone, pance che crescono: non è un bello spettacolo! Ma non è
per questo che vi giunge la nostra lettera. Non siamo preoccupati per il vostro
stress, e nemmeno per il fatto che il cosiddetto senso della realtà vi sta abbandonando.
A preoccuparci è la vostra inarginabile inclinazione alla retorica. Chi fra voi
è sulla scena politica non può farne a meno: è così da sempre, fa parte del
gioco e del mestiere. Il “conservatore” moralista François Fillon, classe 1954,
in corsa per l’Eliseo, preferendo - così diceva - “le parole che salvano a
quelle che seducono”, assegnava intanto falsi impieghi ai parenti per oltre un
milione di euro. Il cinquantaduenne premier russo Dmitrij Medvedev, uso a
richiamare “con pieno senso di responsabilità il nostro bene e il bene generale
della società”, è ambiguo titolare di conti offshore, piste da sci private,
ville con piscina ed eliporti, aziende vinicole in Toscana. Niente di nuovo,
per carità. Nessuno è nato ieri. Ma il punto è che questi babbi non si limitano
a razzolare male, si impegnano con eccessivo (e sospetto) slancio a predicare
benissimo. Anche dalle nostre parti, la sera a tavola - così come nei corsivi
di prima pagina - fanno un uso smodato di retorica, oltre il livello di
guardia. Come il sale per gli ipertesi, non è buona norma. Guardate cosa è
successo all’ex direttore del “Sole 24 Ore”: tutte le domeniche pronto a
infliggerci la sua omelia laica, è finito indagato per falso in bilancio. Fosse
pure innocente su un piano giuridico, non lo sarebbe comunque al tribunale
delle false coscienze. Dante gli farebbe indossare - come minimo! - il mantello
degli ipocriti: dorato fuori, di piombo dentro. In uno dei suoi ultimi
editoriali, Roberto Napoletano puntava il dito, nell’ordine, contro «furbetti
del cartellino», «corruttele varie e sistemiche», «distribuzione di seggiole e
poltrone», «vecchie e nuove clientele». Cito alla lettera: «Tornano le ombre
dei soliti maestri dell’eterno galleggiamento italiano in un Paese sospeso che
fugge dalle sue responsabilità. Promana da tutto ciò una sensazione mista di
nausea e di disorientamento» (“Il Sole 24 Ore”, 26 febbraio 2017, a undici
giorni dall’avviso di garanzia). Impressionante: come il protagonista di un
racconto di Savinio che sentiva odore di morte dappertutto, senza capire che a
emanarlo era lui. La chiusa dell’articolo? Canonica: sull’Italia che «brucia il
futuro dei nostri giovani». Non che il faraonico stipendio di Napoletano -
93mila euro lordi mensili, pare - contribuisse a spegnere le fiamme, ma
l’ipocrisia è perfino più colpevole. L’aspetto psicologico della questione è
avventuroso: che cosa spinge stimati e solitamente spietati professionisti (del
giornalismo, della politica, della finanza, dell’industria) ad ammannirci
quintali di retorica moraleggiante? Qual è il vantaggio interiore del
trombonismo, per chi lo pratica?
venerdì 21 aprile 2017
Scriptamanent. 91 “Un sapere pret-à-porter”.
Da “Un sapere pret-à-porter” di Maurizio Ferraris, pubblicato sul quotidiano la Repubblica del 21
di aprile dell’anno 2013: Lo scrittore inglese Sebastian Faulks ha
recentemente sostenuto che le nuove generazioni saranno le prime in cui i figli
saranno meno colti dei loro genitori: «I ragazzi che oggi hanno vent’anni e più
costituiranno la prima generazione in Europa occidentale a soffrire di una
perdita di sapere e conoscenza a causa della tecnologia. I nostri figli,
difatti, sanno meno cose rispetto ai loro genitori». Uno potrebbe obiettare, come
il presidente Clinton a proposito del sesso: «Dipende da cosa si intende con
“sapere”». C’è un senso, tutt’altro che trascurabile, in cui l’asserzione di
Faulks è letteralmente falsa. (…). Nel mondo di Internet assistiamo a un
fenomeno che, nel suo complesso, può essere considerato un frutto
dell’illuminismo, della capacità delle persone di pensare con la loro testa: la
gente cerca, si documenta, discute. Che poi il frutto di questi pensieri
autonomi possa non piacere, magari risultando arrogante come talora sono le
idee degli autodidatti, è un fatto. Ma questa è un’altra storia, e comunque non
è vero che “Internet rende stupidi”, come ha sostenuto Nicholas Carr con un
pessimismo non meno eccessivo dell’ottimismo con cui Pierre Lévy parlò, negli
anni Novanta, di “intelligenza collettiva” del web. Presuntuosi magari sì, ma
non stupidi. Quello che avverrà, quello che sta avvenendo e viene stigmatizzato
da Faulks, riguarda piuttosto una trasformazione della cultura (…). L’idea di
fondo è questa: le due pagine, quella di carta e quella su web, non si
equivalgono per molti e ovvi motivi, uno dei quali è particolarmente cruciale.
La pagina di carta invita al silenzio e alla concentrazione, la pagina web
(posto che questa espressione abbia un senso) invita alla connessione e alla
deconcentrazione. Se la pagina web dovesse scacciare definitivamente la pagina
di carta non sarebbe la fine dell’intelligenza né dell’istruzione, ma di quel
campo di concentrazione che è stata l’alta cultura nella tradizione
occidentale. È proprio in questa direzione che vanno le considerazioni di
Faulks, che sostiene di non essere un bigotto pessimista, e di apprezzare i
vantaggi delle nuove tecnologie, ma ritiene che «questi giovani hanno accesso
al sapere semplicemente premendo un pulsante, ma, allo stesso tempo, oggi non
hanno più bisogno di “catturarlo”». In che cosa consiste la “cattura”
tradizionale del sapere? (…). …il web esercita una funzione superficialmente
democratizzante, ma nel fondo risulta sottilmente classista, perché di fatto
accresce il divario tra chi è cresciuto in una casa con libri e chi è cresciuto
in una casa senza libri, visto che la scuola e l’università (le vere
responsabili, torno a dirlo) sembrano avere abdicato alla difesa della cultura
cartacea. (…).
Iscriviti a:
Commenti (Atom)