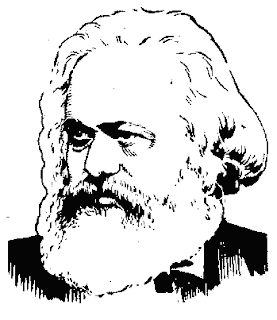Da “Il senso
dei greci per il dolore” di Umberto Galimberti, pubblicato sul settimanale
“D” dell’11 di luglio dell’anno 2015: È il coraggio - l'unico che la saggezza può
dare - di guardare in faccia la condizione tragica dell'uomo. Senza darsi colpa
dei pensieri che in questi estremi ci assalgono. Il dolore non è mai un evento
solitario che riguarda solo chi è afflitto dal male. Il dolore investe anche
chi è accanto a chi soffre e vede la sua vita rattrappirsi e raccogliersi in
quegli sguardi che impietosamente non mentono su un futuro che non c'è più e
nel ricordo di un passato felice che non ritorna. Resta solo un assoluto
presente che reitera di giorno in giorno le pratiche di cura, neppure
accompagnate, (…), da uno spiraglio di speranza. La coscienza è combattuta tra
il desiderio che l'evento si compia per ricominciare a vivere e il senso di
colpa per aver osato concepire un simile pensiero. Gli altri non capiscono e
diradano la loro frequentazione, perché sanno di non avere parole che sappiano
sinceramente consolare. La solitudine si fa abissale. E non c'è fede che tenga,
talvolta neppure la forza di sostenere la cura quotidiana. (…). Il bisogno di
vita, per ora compresso in una successione di giorni senza tempo e senza meta,
non è solo un sogno, una prospettiva per ora conculcata, ma anche ciò che la
sostiene e le consente di reggere l'esperienza della tragicità dell'esistenza. Questa
fa la sua comparsa dove i sogni, i progetti, le aspirazioni del nostro io si
scontrano con la crudeltà innocente della natura che, inaspettatamente, ci fa
conoscere che sono nelle sue mani e non nelle nostre le sorti della nostra
esistenza. I Greci (…) queste cose le sapevano perché non si affidavano a
cieche speranze, e per questo Nietzsche parla di loro come del popolo più
grande mai apparso sulla terra, perché, a differenza degli altri popoli: «hanno
avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore». I Greci erano tragici, non
perché pessimisti, ma perché avevano colto l'aspetto tragico dell'esistenza
umana che, a differenza di quella animale, per vivere ha bisogno di costruire
un senso, in vista della morte che di ogni senso è l'implosione. Per questo, a
Re Mida che chiedeva quale fosse la cosa migliore e più desiderabile nella
vita, il saggio Sileno risponde: «Stirpe miserabile ed effimera, figlio del
caso e della pena, perché mi costringi a dirti ciò che per te è vantaggioso non
sapere? Il meglio per te è assolutamente irraggiungibile. Non esser nato, non
essere, essere niente. Ma la seconda cosa migliore per te è morire presto». Per
questo, scrive ancora Nietzsche, la tragedia non è un genere letterario, ma la
perfetta descrizione della condizione umana, la cui consapevolezza si estinse
con la fine della grecità. E Karl Jaspers, di rincalzo: «Neppure Shakespeare è
un tragico, perché ormai vive nell'era della speranza cristiana». (…).
"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi

"Il bruco" (2017). Nikon Coolpix P900. Foto macro. Stato larvale della falena diurna "Macroglossum stellatarum" volgarmente detta "sfinge colibrì".
martedì 11 luglio 2017
domenica 9 luglio 2017
Paginatre. 92 “Migranti&Welfare”.
Da “Meno
frontiere per sostenere il welfare” di Ferdinando Giugliano - editorialista
di Bloomberg View – pubblicato sul settimanale A&F del 3 di luglio 2017: (…). La
premessa è che l'Unione ha bisogno di immigrazione per mantenere la
sostenibilità del suo sistema di welfare. Oggi all'interno dell'Ue ci sono
quasi quattro cittadini in età lavorativa per ogni persona con più di 65 anni.
A partire dal 2050, questa proporzione dovrebbe essere soltanto di due a uno,
secondo le proiezioni di Eurostat. A meno di ipotizzare un improvviso quanto
improbabile boom delle nascite, l'unico modo per mantenere sotto controllo la
spesa sanitaria e pensionistica è quello di aprire le frontiere a giovani
provenienti da altre parti del mondo. Non ci si può illudere, però, che questo
sia un processo semplice. Come dimostrato dai primi studi condotti sui
rifugiati che si sono stabiliti in Germania, il loro inserimento nel mercato
del lavoro è tutto tranne che agevole. Secondo dati dell'Agenzia Federale del
Lavoro tedesca, il tasso di occupazione fra i rifugiati è di appena il 17%. In
una recente intervista al Financial Times, Aydan Özo?uz, commissaria per
l'immigrazione del governo tedesco, ha ammesso che tra cinque anni fino a tre
quarti dei rifugiati presenti in Germania saranno ancora senza lavoro. E'
pertanto necessario un investimento molto copioso e di lungo periodo per
gestire la transizione. Questo va in direzioni molteplici: prima di tutto, il
salvataggio di coloro i quali scelgono di attraversare il Mediterraneo, spesso
in condizioni disumane. Poi la difficile identificazione, per stabilire ad
esempio se l'immigrato sia un rifugiato a cui va dato asilo politico, oppure un
migrante economico, che i governi possono decidere di non accogliere. Infine le
spese di integrazione, che vanno dai corsi di lingua a uno spesso lontano ma
necessario programma di inserimento nel mondo del lavoro. Fino ad ora la
strategia europea è stata quella di finanziare collettivamente solo una minima
parte di queste spese. Il budget dell'agenzia Frontex, che si occupa di gestire
le frontiere comuni dell'Europa, è cresciuto in questi anni ma si fermerà nel
2017 ad appena 300 milioni. La maggior parte degli oneri continueranno ad
essere invece a carico degli Stati membri. Se di solidarietà si può parlare,
essa si manifesta soltanto nel permettere ai Paesi con i conti pubblici non in
ordine, come l'Italia, di aumentare il loro deficit oltre quanto previsto dalle
regole. Il debito, però resta sulle spalle dei loro contribuenti.
Un'alternativa migliore sarebbe quella di creare un fondo comune a cui
attingere per le spese legate alla crisi migratoria. Per esempio, come ha
proposto un gruppo di accademici tra cui Lucrezia Reichlin nel rapporto
"Making the Eurozone More Resilient", si potrebbe pensare a delle
obbligazioni comuni emesse esclusivamente per finanziare questo tipo di
progetti. Dalla Germania all'Italia, chiunque potrebbe attingere a questi
fondi, mentre toccherebbe alla Commissione Europea monitorarne utilizzo. Chi
non volesse accogliere rifugiati si prenderebbe parte del debito senza però
spendere le risorse. Queste obbligazioni comuni sarebbero il modo migliore per
riconoscere che l'immigrazione è realmente un problema europeo. La loro buona
gestione potrebbe essere un modello anche per altre aree di bilancio,
contribuendo così indirettamente al rafforzamento dell'unione monetaria.
domenica 2 luglio 2017
Quodlibet. 7 "Il capitalismo ha bisogno di regole".
Da "Il
capitalismo ha bisogno di regole per tornare al servizio della
collettività" di Anais Ginori, intervista all’economista Thomas
Piketty pubblicata sul quotidiano la Repubblica del 2 di luglio dell’anno 2016:
(…).
La Brexit rappresenta anche la fine di un ciclo della globalizzazione? "Si
avverte sempre di più la necessità di una regolamentazione del capitalismo.
Abbiamo bisogno di istituzioni democratiche forti che possano limitare la
crescita delle disuguaglianze, e rovesciare il rapporto di forza. La potenza
del Mercato e dell'innovazione economica deve essere messa al servizio dell'interesse
generale. È sbagliato pensare che tutto si risolve in modo naturale. Lo abbiamo
visto in passato".
Quando? "Nel primo ciclo della
globalizzazione, tra l'Ottocento e il 1914, quando la fede cieca
nell'autoregolazione dei mercati ha provocato disuguaglianze, tensioni sociali,
crescita dei nazionalismi, fino alla guerra mondiale. Dopo, c'è stata una fase
storica nella quale le élite occidentali hanno avviato riforme sociali,
fiscali, mettendo un freno alle disparità. A partire dagli anni Ottanta, siamo
entrati in una nuova fase di deregulation legata a diversi fattori, tra cui le
rivoluzioni conservatrici anglosassoni, la caduta dell'Urss".
Non vede nessun segnale di autocritica? "Purtroppo
la crisi del 2008 non ha prodotto alcun cambio sostanziale. Resta la fede
nell'autoregolazione dei mercati e nella sacra libera concorrenza, nonostante
le disuguaglianze provocate. Se non si riuscirà a dare una risposta con
politiche progressiste resterà la tentazione di trovare dei capri espiatori: il
polacco nel Regno Unito o il messicano negli Stati Uniti. Ci saranno sempre
responsabili politici che cavalcheranno questi sentimenti".
Come Donald Trump o Marine Le Pen? "Molti
dei leader populisti e xenofobi appartengono a categorie di privilegiati che
spiegano alle classi popolari bianche che i loro nemici non sono i miliardari
bianchi, bensì altre classi popolari nere, immigrate, musulmane. È un modo di
distorcere l'attenzione dai problemi del sistema capitalistico".
Cosa fare contro il ritorno dei nazionalismi?
"Il quadro in Europa non è così nero. Rispetto agli Stati Uniti o alla
Cina, continuiamo ad avere un modello sociale di sviluppo molto più
soddisfacente. Al tempo stesso, l'Europa soffre di una frammentazione politica,
con Stati-nazione ancora in competizione gli uni con gli altri. All'interno
dell'Ue c'è un dumping sociale, fiscale. L'esempio più evidente è la mancata
volontà di unificare l'imposta sulle società. Le classi medie hanno
l'impressione che i più privilegiati pagano meno di loro. Queste disuguaglianze
alimentano i populismi di destra e la nascita di movimenti come Podemos o
Syriza".
Perché ha accettato di lavorare come
consigliere di Podemos? "Pablo Iglesias o Alexis Tsipras non sono perfetti
ma sono molto meno pericolosi dei nazionalisti polacchi o ungheresi. Basta
vedere gli sforzi che la Grecia fa per accogliere i rifugiati. Nel caso della
Spagna ci vorrebbe un atto di coraggio, ovvero una moratoria sul debito
pubblico, per invertire tendenza su crescita e disoccupazione. Solo così Psoe e
Podemos potrebbero formare un governo. E ci sarebbe un cambio di maggioranza
politica nell'Unione. La Francia, l'Italia e la Spagna rappresentano insieme il
50% del Pil rispetto al 27% per la Germania".
Perché ha interrotto la collaborazione con
il leader laburista Jeremy Corbyn? "Non avevo tempo di partecipare alle
riunioni. Nessun legame con la campagna sulla Brexit. In sei mesi, non sono mai
riuscito ad andare agli incontri del Labour. Nel caso di Podemos, sono stato
invece più volte a Madrid. Pablo Iglesias è anche venuto a Parigi".
Ha contatti con partiti italiani? Potrebbe
collaborare con il Movimento 5 Stelle? "No, francamente non credo proprio.
Ho invece parlato con alcuni collaboratori di Matteo Renzi, soprattutto per
esprimere il mio scetticismo. Sulla riforma dell'eurozona, speravo che Renzi
fosse più ambizioso. Invece si è accontentato di qualche aggiustamento
marginale".
Forse perché la Germania è inflessibile su
certi punti? "Se l'Italia, la Francia e la Spagna mettessero sul tavolo un
proposta di unione politica e finanziaria con un parlamento dell'eurozona
competente sul livello di deficit e sulla ristrutturazione dei debiti sovrani,
allora la Germania non potrebbe mettere i bastoni tra le ruote. Invece la
Francia non ha fatto niente per l'Europa del Sud, assecondando la Germania per
avere gli stessi tassi d'interessi. Mentre Berlino continua ad avere un
atteggiamento insopportabile".
A quale atteggiamento si riferisce? "Avere
l'8% del Pil di eccedenza nella bilancia commerciale non serve a niente. La
Germania deve investire nel paese e aumentare i salari. Già durante la prima
fase globalizzazione la Francia e il Regno Unito avevano accumulato per decenni
eccedenze commerciali. Un'aberrazione. L'unico motivo, più o meno esplicito, è
una volontà di dominazione su altri paesi. È una patologia della
globalizzazione che purtroppo si ripete adesso".
Iscriviti a:
Post (Atom)